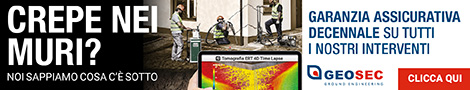Condono edilizio e sanatoria ordinaria: il Consiglio di Stato sull'inefficienza della P.A.
Il Consiglio di Stato chiarisce le differenze tra condono edilizio e sanatoria ordinaria oltre a mettere in risalto le inefficienze della pubblica amministrazione
Il silenzio della pubblica amministrazione ad una richiesta di permesso di costruire in sanatoria ha effetti molto differenti a secondo che si tratti di un'istanza di condono edilizio o di accertamento di conformità. A spiegarne le differenze (anche tra i due istituti) ci ha pensato il Consiglio di Stato che con la sentenza del 22 maggio 2023, n. 5072 ci consente di dettagliarne i contorni.
Indice degli argomenti
-
Condono edilizio e sanatoria ordinaria: interviene il Consiglio di
Stato
- Esecuzione
giudicato
-
Condono edilizio e accertamento di conformità: le
differenze
- Il cambio di
destinazione d'uso
- Il
silenzio della pubblica amministrazione
- Le ragioni del
silenzio-assenso
- La certificazione del
silenzio
- One shot temperato
doppia chance
- Conclusioni
-
La pandemia può essere una motivazione dell'allungamento dei
tempi?
Condono edilizio e sanatoria ordinaria: interviene il Consiglio di Stato
Il ricorso al Consiglio di Stato è stato presentato per l'ottemperanza di una precedente sentenza avente ad oggetto il diniego di condono per cambio di destinazione d’uso. Il caso trae le sue origini dal rigetto di un'istanza di condono edilizio presentata ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 326/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003 (c.d. terzo condono edilizio), e della Legge della Regione Lazio n. 12/2004, presentata in relazione al parziale cambio di destinazione d’uso, da magazzino a negozio, di un locale.
Mentre in primo grado il TAR aveva rigettato il ricorso sull’assunto che non sarebbe stata provata l’avvenuta realizzazione dell’intervento in epoca antecedente al 31 marzo 2003 (termine ultimo per la fruizione dell’invocato “terzo condono edilizio”), in secondo grado il Consiglio di Stato aveva ribaltato la sentenza, rilevando che nel caso di modifica di destinazione d'uso senza opere si sarebbe potuto applicare il regime delle sanatorie ordinarie ben potendo l’interessato adibire l’immobile ad esercizio commerciale, giusta la sua insistenza in una zona omogenea che ammette la presenza tanto di negozi, quanto di magazzini.
A nulla varrebbero i rilievi operati dal Comune e dal TAR che avevano basato il diniego sulla necessità di adeguare l'impianto elettrico. Da qui l'accoglimento del ricorso a cui è seguita una prima nota dell'interessato e una seconda inviata a due anni di distanza in cui, a fronte della perdurante inerzia degli uffici, in cui si diffidava il Comune ad avviare e concludere il procedimento di rilascio del condono.
Quindi il secondo ricorso al Consiglio di Stato in cui l'interessato ha quindi l’ottemperanza della ridetta pronuncia. Ricorso che i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto fondato per le ragioni di seguito esplicitate.
Esecuzione giudicato
I giudici del Consiglio di Stato hanno premesso che l’Amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e per nessuna ragione di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica può sottrarsi a tale obbligo, non avendo, in proposito, alcuna discrezionalità per quanto concerne l'emanazione o meno ed il momento dell'emanazione, ma esclusivamente in ordine alla forma e agli eventuali elementi accidentali.
Nel caso di specie, invece, alla prima sentenza del Consiglio di Stato l'amministrazione ha risposto con una nuova richiesta di integrazione documentale. Il Consiglio di Stato ha, però, ritenuto che in generale il tardivo avvio di un procedimento sottoposto al regime del silenzio assenso (come il condono edilizio), mediante nuova richiesta di documentazione, senza chiarire le tempistiche finali di definizione dello stesso, ovvero senza specificare le sopravvenienze che ne hanno reso necessaria l’acquisizione anche in riferimento a situazioni, di fatto e di diritto, ormai cristallizzate nel giudicato, non possa essere equiparato alla doverosa ottemperanza allo stesso.
Condono edilizio e accertamento di conformità: le differenze
Tra le altre cose, la sentenza da ottemperare afferma che il ricorrente, per la legittimazione postuma del proprio intervento, avrebbe potuto attingere anche al paradigma dell’accertamento di conformità di cui agli artt. 7 della l.r. n. 36 del 1987 e 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, anziché alla disciplina del condono di cui all’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 326.
La scelta è giustificata, in termini di convenienza, stante che «fermo comunque restando l’obbligo di corrispondere in entrambi i casi la somma dovuta a titolo di incremento degli oneri di urbanizzazione, il pagamento dell’oblazione prevista per il condono di cui all’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 convertito con l. n. 326 del 2003 presumibilmente risultava più vantaggioso per l’attuale appellante rispetto al pagamento della sanzione contemplata dagli anzidetti art. 36 del t.u. approvato con d.p.r. n. 380 del 2001 e art. 22 della l.r. n. 15 del 2008».
L’accertamento di conformità o “sanatoria ordinaria” consiste nella regolarizzazione di abusi “formali”, in quanto l’opera è stata sì effettuata senza il preventivo titolo o in difformità dallo stesso, ma senza violare la disciplina urbanistica vigente sia al momento della sua realizzazione che a quello di presentazione della domanda.
Invece, il “condono” (termine che il Consiglio di Stato ammette non figuri in alcun testo legislativo, complice una certa "ritrosia linguistica" ad utilizzare una parola evidentemente evocativa della portata sanante di situazioni “sostanzialmente” illecite) produce l’effetto di estinguere anche l’illecito penale per il tramite del previo pagamento di una sanzione pecuniaria.
In particolare, in Italia si sono succedute tre leggi di condono, delle quali viene qui in evidenza la terza (art. 32 della più volte ricordata l. 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del d.l. 30 settembre 2003, n. 269), che ha esteso la disciplina dell’istituto, quale risultante dai capi IV e V della l. n. 47/1985, come modificati dall’art. 39 della l. n. 724/1994, alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003, seppure ponendo l’ulteriore limite che esse non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30 % della volumetria originaria o, in alternativa, superiore a 750 metri cubi.
La riconosciuta sussistenza dei requisiti per avanzare sia un’istanza di sanatoria ordinaria che di condono, implica l’affermazione che nel caso di specie sussiste anche il requisito della doppia conformità, seppure non necessario in relazione al percorso seguito.
Il fatto che le finestre temporali, pure prorogate, per accedere al condono si siano chiuse rispettivamente il 30 novembre 1985, il 31 marzo 1995 e, per quanto qui di interesse, il 10 dicembre 2004, non ha comunque reso obsoleto l’istituto.
Il Consiglio di Stato scrive "sebbene siano trascorsi decenni dalla presentazione delle istanze, infatti, non sono pochi i Comuni italiani presso i quali tali pratiche sono ancora in attesa di definizione, cosicché anche questa tipologia di istanza, al pari di quella ordinaria, deve essere tenuta presente in sede di vaglio delle sanatorie edilizie", a conferma di una certa "inerzia" o difficoltà della pubblica amministrazione.
Il cambio di destinazione d'uso
Tra le altre cose, l'interessato ha presentato la propria istanza di condono senza fare riferimento agli interventi sull’impiantistica elettrica. A ciò il Consiglio di Stato, tuttavia, non ha inteso attribuire alcuna rilevanza omissiva, giusta la ritenuta inconsistenza degli stessi sotto il profilo edilizio. Peraltro solo stralciando dalla nozione di “opere” ridetta tipologia di interventi, ha potuto connotare come meramente funzionale il cambio di destinazione d’uso effettuato dal ricorrente.
Ciò rende non del tutto intellegibili, se non incoerenti, talune delle richieste integrative avanzate dalla pubblica amministrazione, in quanto apparentemente riferite proprio alla necessità di qualificare l’abuso, quantificandone la consistenza, pur identificandosi essa necessariamente con la mera indicazione della superficie del negozio e del laboratorio, agevolmente desumibili, oltre che dalla istanza di condono, dai contenuti della comunicazione di avvio dell’attività commerciale resa ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 114 del 1998.
Come la sentenza prima sentenza del Consiglio di Stato aveva già chiarito, la modifica di destinazione d’uso non costituisce una tipologia di intervento edilizio ex se, bensì piuttosto il suo effetto giuridico.
Non a caso la relativa dizione non figura nell’elenco delle definizioni contenuto nell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, ma compare nelle singole declinazioni delle stesse, ora quale limite negativo (come per la manutenzione straordinaria, limitatamente ai cambi urbanisticamente rilevanti), ora, al contrario, come possibile esemplificazione contenutistica (come per il restauro e risanamento conservativo di cui alla successiva lettera c) del medesimo art.3, che comprende anche il cambio delle destinazioni d’uso, purché compatibile con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso che i relativi interventi devono comunque rispettare).
La rilevanza sotto il profilo urbanistico del cambio di destinazione d’uso eleva ad intervento assentibile anche quello non accompagnato da alcuna opera edilizia, ancorché minima, denominato appunto “funzionale”, per enfatizzarne il riferimento al mero utilizzo dell’immobile, a prescindere dagli adattamenti che si siano resi necessari allo scopo.
Ad oggi ridetta rilevanza è agevolmente individuabile in ragione della categorizzazione declinata nell’art. 23 ter, inserito nel T.u.e. col c.d. decreto legge “Sblocca Italia” (inapplicabile ratione temporis al caso di specie). Le cinque categorie ivi contemplate, che le leggi regionali possono solo precisare, ma non derogare, rispondono al preciso intento di omogeneizzare su tali aspetti le scelte di governo del territorio, evitando frammentazioni, finanche terminologiche, sicuramente contrarie ai più elementari principi di certezza del diritto e foriere di oneri aggiuntivi per i cittadini-utenti.
La sentenza ottemperanda ha alla fine convenuto sulla opportunità di “sanare” lo stato di fatto dell’avvenuto passaggio da magazzino a deposito «quale legittimazione all’inserimento nel locale tessuto urbanistico di un abuso consumato con riguardo ad un utilizzo dell’immobile comunque conforme alla strumentazione urbanistica vigente». Allo scopo, si è preoccupata di giustificare la ritenuta assentibilità postuma tramite condono sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della norma, che non può che applicarsi anche «a coloro che hanno perpetrato abusi ben meno gravi rispetto a coloro che hanno agito in dispregio alle norme di legge non richiedendo al tempo dovuto il rilascio del titolo edilizio ovvero, in dispregio alle norme urbanistiche, realizzando opere dalle stesse vietate ovvero adibendo immobili ad utilizzi dalle norme medesime parimenti inibiti».
Va ricordato che il regime procedurale per la definizione delle pratiche di condono è contenuto nell’art. 35, comma 17, della l. n. 47/1985, il quale prevede che «Fermo il disposto del primo comma dell’articolo 40 [rappresentazione dolosamente infedele]e con l’esclusione dei casi di cui all’articolo 33 [contrasto con vincoli nominativamente indicati ], decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento».
Il silenzio della pubblica amministrazione
Per quanto nel caso di specie il ricorrente non invochi l’avvenuta formazione del silenzio assenso successivamente al giudicato, la circostanza che il legislatore abbia previsto tale modalità di acquisizione del titolo – contrariamente, peraltro, a quanto accade per l’accertamento di conformità – non può essere priva di conseguenze.
L’efficacia delle scelte di semplificazione dei regimi di accesso a determinate attività, che il legislatore ha tentato via via di rafforzare introducendo ulteriori rimedi ed accentuando gli elementi di garanzia della certezza delle situazioni giuridiche, si gioca preliminarmente sul piano delle "prassi distorte degli uffici", che si collocano astrattamente a monte dello stesso avvio dei procedimenti.
La presunta incompletezza di una pratica, infatti, finisce per diventare il grimaldello per uno stillicidio di richieste aggiuntive, spesso ammantate dall’egida della consultazione collaborativa, tali comunque da procrastinare sine die il perfezionamento dei procedimenti ad istanza di parte.
In altre parole, una lettura degli istituti di semplificazione, tra i quali sicuramente rientra anche il silenzio assenso, che sia conforme ai principi generali dell’attività amministrativa, impone che il comportamento dell’Amministrazione, al pari di quello del privato, sia improntato alla correttezza e alla buona fede, come peraltro oggi espressamente codificato dall’art. 1 della legge n. 241 del 1990 (comma 2-bis, inserito dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, che ha positivizzato principi comunque ritenuti immanenti al sistema).
Un’ingiustificata attesa nell’avvio dell’istruttoria di una pratica, laddove la stessa non sia prima facie del tutto priva dei requisiti minimi di esaminabilità in concreto, non solo non può impedire la decorrenza del termine di maturazione del silenzio assenso, ove previsto, ma a maggior ragione impone la successiva compressione dei tempi di chiusura della stessa, “rimediando” per quanto possibile al pregresso colpevole ritardo nei confronti della legittima aspettativa del cittadino a conoscere il contenuto e le ragioni, qualunque esse siano, delle scelte dell’amministrazione.
Diversamente opinando egli si ritroverebbe anacronisticamente relegato in un ruolo di suddito, continuamente esposto al rischio di vedersi procrastinare il dies a quo per consolidare la propria situazione, in sostanziale dispregio di qualsivoglia tentativo alleggerimento degli oneri e in totale antitesi con la stessa nozione di semplificazione o liberalizzazione delle attività economiche.
Le ragioni del silenzio-assenso
Il meccanismo del “silenzio-assenso” risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l’inerzia equivale a provvedimento di accoglimento, nel senso che gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell’atto amministrativo. Con il corollario che, ove ne sussistano i requisiti di formazione, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge.
Come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, reputare che la fattispecie sia produttiva di effetti soltanto ove corrispondente alla disciplina sostanziale, significherebbe sottrarre i titoli così formatisi al regime della annullabilità, per contro espressamente prevista.
L’art. 21 novies della l. n. 241 del 1990, infatti, nel disciplinare in generale l’istituto dell’annullamento d’ufficio, ne individua l’oggetto (anche) nel «provvedimento [che] si sia formato ai sensi dell’art. 20», con ciò presupponendo evidentemente che la violazione di legge non incida sul perfezionamento della fattispecie, bensì rilevi (secondo i canoni generali) in termini di illegittimità dell’atto. Da qui il rimedio postumo che l’ordinamento appronta per l’Amministrazione che si ravveda e ravvisi la necessità di rimediare agli effetti del proprio indebito comportamento inerte.
La certificazione del silenzio
Indicazioni ancora più chiare nel senso della finalità acceleratoria dell’agire amministrativo dell’istituto sono rinvenibili nella recente -e non aliena da criticità- disciplina della c.d. “certificazione del silenzio”, nonché della sanzione di inefficacia delle decisioni tardive rispetto alla significatività attribuita al decorso del tempo dal legislatore.
La formulazione del comma 8, dell’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001, avente ad oggetto il procedimento di rilascio del permesso di costruire “ordinario”, è stata infatti integrata con la previsione che «Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti».
Vero è che analoga indicazione non è stata inserita con riferimento ai procedimenti di condono, ma è tuttavia emblematico delle criticità gestionali diffuse in ambito urbanistico-edilizio il fatto che la previsione dell’art. 20 del T.u.e. sia un’anticipazione di quanto successivamente esteso a tutti i provvedimenti per silentium.
Il comma 2 bis dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, infatti, inserito dal successivo d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, prevede ora, in maniera peraltro neppure del tutto sovrapponibile, che: «Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo […]».
La disposizione si completa addirittura con la facoltà riconosciuta al privato, decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, di sostituire l’attestazione con una propria dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. E’ ancora una volta evidente lo sforzo del legislatore per recuperare efficacia e conseguente attrattività all’istituto, giusta la riscontrata comprensibile riluttanza del privato-cittadino all’utilizzo di un titolo tacito e non alla sua “materializzazione” sul piano formale, a torto o a ragione percepita come più cautelante a fronte di un eventuale controllo. Il tutto, ovviamente, lasciando inevitabilmente immutata la struttura essenziale del provvedimento tacito, comprensiva delle scansioni temporali che ne determinano la formazione.
Il silenzio-assenso non può essere ritenuto la modalità “ordinaria” di svolgimento dell’azione amministrativa. Così come, pertanto, al cittadino che lo invoca o che comunque può beneficiarne, va richiesto un comportamento responsabile e collaborativo, evitando l’inoltro di istanze-scatole vuote, ovvero, peggio ancora, del tutto eterogenee rispetto al paradigma procedimentale invocato (si pensi, a mero titolo di esempio, all’utilizzo palesemente improprio di procedimenti dichiarativi, quali in particolare la CIL o la CILA); in egual misura l’Amministrazione è tenuta al rispetto delle scansioni procedurali previste e, ancor prima e a prescindere, ad un comportamento che non si palesi come inutilmente e immotivatamente dilatorio, seppure formalmente e astrattamente corretto.
Va da sé, dunque, che tutto si sposta sul piano delle responsabilità, giusta la previsione di cui all’articolo 2 della l.n. 241 del 1990 secondo cui «la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente».
In tale cornice, si colloca anche l’annosa questione dell’ampiezza del potere amministrativo in sede di sua riedizione a seguito di un pregresso giudicato, da sempre al centro del dibattito dottrinario e giurisprudenziale.
One shot temperato doppia chance
Per conferire effettività ai rimedi giurisdizionali, è stata perfino elaborata la (discussa) teoria del cosiddetto “one shot temperato” o della “doppia chance”, in forza della quale l’amministrazione pubblica che abbia subito l’annullamento di un proprio atto potrebbe rinnovarlo una sola volta e, quindi, dovrebbe riesaminare l’affare nella sua interezza, sollevando, una volta per tutte, ogni questione che ritenga rilevante, senza tornare in seguito a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili non ancora esaminati.
Sul piano normativo, la medesima esigenza di concentrazione ed effettività di tutela ha ispirato le modifiche apportate dall’art. 12 del più volte richiamato d.l. 16 luglio 2020, n. 76 all’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990. La natura sostanziale o processuale della disposizione (il c.d. processualprocedimento) e il conseguente impatto della novella sulla validità del provvedimento elusivo comunque adottato, secondo la (nuova) disciplina dell’art. 21 octies, ha dato adito a pronunce contrastanti.
Nel caso di specie, i contenuti dell’originario preavviso di rigetto assumono rilievo solo in quanto è in riscontro dello stesso che l’interessato ha fornito la documentazione (fatture, preventivi e altro) che il Consiglio di Stato ha ritenuto probanti dell’avvenuta realizzazione della modifica prima del termine finale previsto dalla legge. Salvo dunque il Comune disponga di elementi sopravvenuti idonei a confutare ridette risultanze, il ricorrente ha ormai compiutamente adempiuto all’onere probatorio che gli incombeva al riguardo, sicché qualsivoglia ulteriore richiesta documentale relativa a tale circostanza costituisce un aggravio procedimentale inammissibile finanche nella più ampia prospettiva di un’ipotetica violazione del principio eurounitario di divieto di gold plating.
L’art. 2, comma 7, della l. n. 241, d’altro canto, consente l’interruzione dei termini per la conclusione di un procedimento «per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni».
Con riferimento al procedimento di rilascio del permesso di costruire l’art. 20 del T.u.e., che costituisce spesso il banco di prova delle difficoltà applicative degli istituti di semplificazione/liberalizzazione, giusta l’esigenza di garantire il perenne controllo sull’assetto del territorio da parte degli Enti territoriali, in maniera analoga consente al responsabile del procedimento di interrompere il termine per il completamento dell’istruttoria una sola volta «entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente».
Conclusioni
In sintesi, la doverosità dell’azione amministrativa e dei suoi tempi rappresenta una peculiare declinazione del principio di legalità, intesa non più solo come limite negativo all’esercizio del potere, ma anche e soprattutto come affermazione in positivo dell’obbligo che ciò avvenga e che avvenga in un tempo utile (o, se si vuole, ragionevole).
Così interpretata, essa si raccorda intimamente al principio di buon andamento o, per usare la più moderna terminologia del diritto europeo, del dovere di buona amministrazione. Ed è in tale contesto che si colloca anche il potere conformativo del giudice amministrativo, in sede di cognizione e, ancor più, in sede di ottemperanza, nella direzione della effettività delle tutele a presidio, appunto, delle legalità e quindi del buon andamento e della efficienza dell’agire pubblico. Una lettura armonica dei principi sottesi alle scelte di semplificazione e liberalizzazione via via rafforzate e ribadite dal legislatore, che si pone a monte dell’esegesi puntuale delle singole norme, pur traendo ragione dal complesso delle stesse, rappresenta la prima cartina di tornasole dell’efficacia di qualsiasi riforma intervenuta al riguardo.
Alla luce di tutto quanto sopra è evidente che il comportamento del Comune, pure dopo il formale (ri)avvio dell’istruttoria del procedimento, senza peraltro indicare alcuna tempistica di chiusura dello stesso, integra il presupposto dell’inottemperanza al giudicato riveniente dalla prima sentenza del Consiglio di Stato.
La pandemia può essere una motivazione dell'allungamento dei tempi?
Nessun rilievo scusante del pregresso ritardo, giusta la consistenza dello stesso, può infatti essere attribuita alle invocate criticità conseguite alla pandemia. Il legislatore ha da subito fornito alla pubblica amministrazione un idoneo strumentario giuridico finalizzato a contemperare le esigenze di tutela della salute del lavoratore con quelle di continuità dei servizi, proprio allo scopo di scongiurarne la totale paralisi. L’utilizzo di modalità alternative alla presenza fisica, infatti, quali lo smart working ovvero le analoghe forme di lavoro c.d. “agile” o da remoto, non si sono risolte in un continuativo, inderogabile e generalizzato divieto di accesso presso le sedi di servizio, ma hanno richiesto da parte datoriale una doverosa analisi dei contenuti delle proprie attività, approntando, ove necessario in relazione alla concreta tipologia delle stesse, sistemi di turnazione rispettosi del distanziamento sociale.
Ne consegue la condanna del Comune ad eseguire la sentenza tenendo conto delle precise statuizione riportate nella stessa (qualificazione e consistenza, nonché epoca di ultimazione, dell’abuso), alla luce delle quali rieditare il proprio potere entro sessanta giorni dal deposito delle integrazioni documentali richieste, ove il ricorrente non ne evidenzi la riconducibilità a dati di fatto già definitivamente acclarati. Solo in caso di protratta inerzia oltre tale termine, all’istruttoria procederà quale commissario ad acta il Prefetto, con facoltà di delega in favore di un funzionario dell’Ufficio U.T.G., il quale, entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al procedimento valutando l’effettiva necessità delle richieste ed eventualmente residue integrazioni istruttorie, nonché all’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.
Così è deciso, l'udienza è tolta.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 22 maggio 2023, n. 5072IL NOTIZIOMETRO