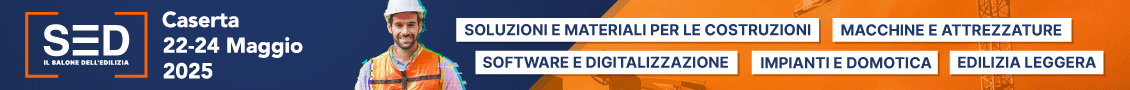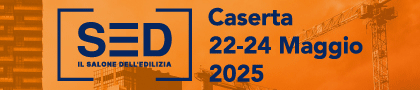Silenzio-assenso: il diritto urbanistico tra progresso e resistenze feudali
Con l’introduzione dell’art. 36-bis al d.P.R. n. 380/2001, il Legislatore ha deciso di estendere il meccanismo del silenzio-assenso alle pratiche di sanatoria semplificata
La grande anomalia italiana
In nessun altro Paese europeo si assiste a un uso così estremo della funzione autorizzativa della PA. In Italia, ogni intervento, seppur minimo o quasi insignificante — come l’ampliamento di una finestra, la chiusura a veranda di un piccolo balcone o persino la realizzazione di una semplice intercapedine semi interrata attorno ad un edificio — deve previamente affrontare un labirinto burocratico, confrontarsi con un groviglio di norme fatto di autorizzazioni, pareri, verifiche, sopralluoghi e timbri, che rimbalzano da un ufficio all’altro. Il cittadino viene trattato come se la sua proprietà fosse cosa pubblica.
E non è tutto: sono le stesse norme ad impedire, di fatto, molte libertà costruttiva. Anche un’intercapedine, un sottotetto o un terrazzo vengono automaticamente considerati superficie utile, con conseguenze sul classamento e sulla rendita catastale, quindi sull’IMU, sulla Tari, sulle bollette etc. Il risultato è che un piccolo ampliamento può far lievitare la classificazione dell’immobile, far scattare oneri di urbanizzazione e costi di costruzione aggiuntivi, fino al paradosso di trasformare, “su carta”, la casa o la masseria di un contadino o di un pensionato in un’abitazione di “lusso” – si veda, per fare un esempio, il D.M. n. 1072 del 2 agosto 1969 – perdendo così le detrazioni fiscali sulla ristrutturazione o altri bonus edilizi, la riduzione dell’iva al 10%, l’esenzione dal pagamento dell’IMU anche se prima casa etc. vedi TUIR (DPR 917/1986) – Art. 16-bis, comma 1.
Così si arriva all’assurdo: un pensionato con 1.000 euro al mese, o un cittadino che guadagna 1.200 euro ma ha bisogno di qualche stanza in più per esigenze sue personali di vita, viene trattato dallo Stato come un miliardario. Una follia grottesca che sancisce un principio inquietante: in Italia, solo i ricchi possono permettersi le più semplici comodità o piccoli spazi abitativi che, altrove nel mondo, non verrebbero nemmeno notati.
Ne deriva una pessima qualità della vita, una stasi economica, un forte disincentivo agli investimenti in immobili, e alle ristrutturazioni, un danno importante per l’intera filiera edilizia che, ricordiamolo, rappresenta uno dei più potenti moltiplicatori economici nazionali.
L’edilizia non è solo fatta di mattoni: è manifattura, trasporti, energia, design, ricerca, innovazione, occupazione; si muovono con la filiera edilizia, innumerevoli figure artigiane: piastrellisti, elettricisti, idraulici, fabbri, falegnami, asfaltisti, guainisti, carpentieri, intonachisti, pittori, cartongessisti, vetrai, ponteggiatori, serramentisti, autisti, impiantisti, frigoristi, mobilieri, e poi i professionisti, come architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti, e naturalmente imprese edili, di trasporto e logistica di materiali, il settore bancario e assicurativo (mutui, fideiussioni, assicurazioni tecniche), la filiera del cemento, dei laterizi, dell’acciaio, del vetro, degli isolanti, delle vernici, del legno, etc. con una mobilitazione economica, che genera una quota diretta sul PIL: tra il 9% e il 10% e con una quota indiretta e indotta (produzione di materiali, impianti, logistica, trasporti, servizi professionali, finanziari e assicurativi collegati), che può arrivare al 20% del PIL; con una occupazione: di oltre 2 milioni di occupati diretti e almeno altri 2 milioni indiretti, che generano un effetto moltiplicatore: ogni euro investito in edilizia genera da 1,5 a 3 euro di PIL nel medio periodo.
INDICE
IL NOTIZIOMETRO